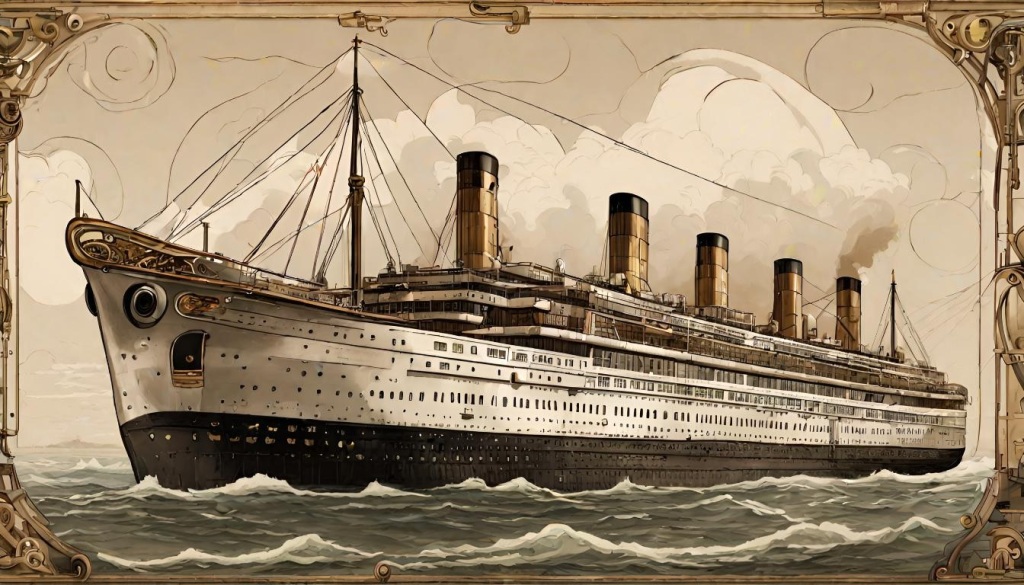Nell’immaginario il transatlantico è assimilabile un mostro marino di acciaio brulicante di umanità; uno spazio in cui la vita è sospesa dalla sua dimensione connaturale di movimento su un piano stabile. Ѐ metafora del lungo transito e, al contempo, evoca una condizione di contenzione da cui non si può uscire se non attendendo lo sbarco; il suo fascino senza tempo è sempre alimentato dal simbolismo del mare quale elemento che rispecchia l’inconscio.
Meditando anche solo su questi aspetti, non esaustivi, è possibile comprendere l’attrattiva che le grandi navi hanno sempre suscitato su scrittori, poeti, cineasti, artisti. Carlo Tosetti non sfugge a questa malia, raggiungendo, tuttavia, con la sua opera poetica La teoria del transatlantico, esiti singolari. Attraverso l’allegoria del transatlantico, infatti, il poeta lombardo compone una partitura socio-politica sulla decadenza della scienza e della tecnica quali mezzi del progresso umano. Il mito dell’evoluzione positivista è mostrato nella sua dissoluzione, sottomesso a un uso e consumo predatori, in spregio dei costi vitali della produzione, privilegiando il piacere mordi e fuggi e paventando un automatismo sempre più invasivo dagli esiti annichilenti.
Il transatlantico di Tosetti, con le sue maestranze e il personale impiegati nel lavoro e i clienti-passeggeri, non è poi così dissimile dai magazzini di Amazon o dai capannoni della instant-moda di Shein: si tratta di giganteschi apparati che, invece di rappresentare una manifestazione della crescita economica e delle possibilità di godimento di beni, finiscono col diventare fauci ingoianti energie, risorse, tempo, in altre parole vite, per la produzione e la distribuzione a un ritmo incontrollato, alimentati dal bisogno indotto di consumo superfluo e antidepressivo.
Il messaggio che sottende l’opera, dunque, è forte e politico, ed è veicolato con una forma estetica geniale molto fedele alla ricerca che il poeta nativo di Milano persegue da anni con successo di critica. Infatti, se il contenuto di La teoria del transatlantico richiama una critica della “società fast food”, la lingua scelta da Tosetti per esprimerlo è coerente, antica nel senso più elevato dell’aggettivo, è scolpita, ricercata, meditata. I versi – calibratissimi – sono un richiamo alla necessità di uscire dall’ingranaggio furioso e spersonalizzante, sono un invito a fermarsi e soffermarsi, a tornare sui propri pensieri e gesti una, due, più volte.
La struttura dell’opera, come chiarito egregiamente da Anna Maria Curci nella prefazione: “ha una sua regolarità, con ripetizioni numeriche significative – sette libri: I. Il transatlantico Albizia, II. Il funzionario del magazzino, III. Il cuciniere, IV. L’addetta all’ufficio reclami, V. Il direttore della compagnia di navigazione, VI. Il passeggero, VII. La teoria del transatlantico, di sette componimenti ciascuno – e una cadenza metrica precisa: ogni componimento dei complessivi quarantanove è una sestina di endecasillabi, nella quale il terzo e il quarto verso sono in rima baciata”. Il lavoro di Carlo Tosetti è dunque certosino, è un amanuense del verso: nulla è lasciato al caso a livello ritmale, figurale e fonetico. Le sezioni mostrano un’architettura poemale, l’opera è un racconto corale in versi e per immagini, evocate da un linguaggio denso di sottesi, originale e visionario, a tratti straniante, nello sforzo di rispettare la raffinata musicalità dell’endecasillabo.
La definizione di “forma chiusa” è per questo libro particolarmente calzante, non solo riguardo alla metrica, ma anche per l’atmosfera da spazio contenitivo e ingranaggio produttivo che è in grado di evocare. La voce di Carlo Tosetti è singolare, difficilmente emulabile, e spicca nettamente in un panorama poetico ormai omologato. Essendo la sua una proposta originale e con una voluta complessità, sposa il rischio di non essere accolta con favore da un pubblico massivo; per contro, possiede un’attitudine apprezzabile anche dai non addetti ai lavori, ossia la restituzione di atmosfere nitide, tangibili, quasi cinematografiche, come nel caso del transtlantico Albizia in pieno stile Belle Époque, epigone del classista Titanic, sempre a rischio di naufragio.
Per concludere, nel noto saggio “L’epoca delle passioni tristi”, gli psicanalisti Miguel Benasayag e Gérard Schmit scrivono: “Viviamo in un’epoca dominata da quelle che Spinoza chiamava le «passioni tristi», cioè l’impotenza e la disgregazione. La fine dell’ideale positivista ha gettato gli uomini nell’incertezza”. Dunque, la crisi della cultura moderna occidentale è legata a doppio filo alla caduta del mito dell’onnipotenza del progesso, al fallimento della promessa di un domani sempre migliore, del futuro quale “redenzione laica” affidata al lavoro dell’uomo. Ne La teoria del transatlantico Carlo Tosetti affida questo stesso monito alla poesia, arte senza mercato per eccellenza e dunque minoritaria, e proprio in virtù di in ciò il suo messaggio appare ancora più sincero e necessario.

Poesie dalla raccolta La teoria del Transatlantico (Edizioni Cofine, 2022):
Libro I – Il transatlantico Albizia
V
Ben prima dell’avvento dei motori
– le navi a kerosene – si viaggiava
a vela in preda a bizze di correnti
o le bonacce, irrispettosi venti.
Vano il conto di scorte da imbarcare,
galleggiavamo in preda a sete e fame.
VI
Sola nemica è la catastrofe, ora:
l’iceberg, sbronzo un capitano nella
tempesta rara e l’isola neonata
– vulcanica germoglia inusitata –
assente dalla mappa. Ciò che affonda
alfine un transatlantico è la storia.
Libro II – Il funzionario del magazzino
VI
La teoria afferma che questi giganti
irremovibili solchino i mari:
non è che apparente il disagio – inetto
quel cuciniere – il sistema perfetto
fende l’atlantico con un coltello
smussato. Che taglia l’acqua è la chiglia.
Libro III – Il cuciniere
III
Lo strepitare elettrico d’insonni
macchinari: impastano, sminuzzano,
si tagliano i tempi e la produzione
aumenta, illude la rivoluzione
del vapore che attenta – non è vita,
l’inganno solca lesto del motore –.
VII
Quindi s’arguisce che alle grandi navi
– dette nelle stanze transatlantici –
apparenza celi approssimazione;
dietro a tanta grandigia c’è un coglione,
un equipaggio intero, il cui lavoro
abbozza falso un lusso che par vero.
Libro IV – L’addetta all’ufficio reclami
I
Dice la teoria del transatlantico
che cammini un mastodonte per i grandi
numeri a favore e anche quando il male
intacca delle cellule, s’avvale
il colosso dell’utile prodotto
e tiri dritto senza pencolare.
Libro V – Il direttore della compagnia di navigazione
II
Il transatlantico regge teoria
– nave infrenabile, erculeo motore –
e prova che basti linfa vitale
– appunto i danari – che dal boreale
emisfero noi si affronti ostinati
le immense procelle, i rischi dei mari.
III
E voi – gli eversivi, i grigi utopisti –
della dignità del duro lavoro,
voi, gli ottocenteschi ancora latrate
di nobiltà nel pelare patate.
Sulle città galleggianti, sfarzose,
vendiamo apparenza, reale finzione.
Libro VI – Il passeggero
I
Spesso viaggio su Albizia, al nuovo mondo
anelo – fertile luogo – lavoro.
Io curo i viaggi di merci, i trasporti.
Con colleghi compagne le consorti
– in prima classe immersi, in grande agio –
traverso l’infinito mare, godo.
Libro VII – La teoria del transatlantico
IV
Che conta è la bellezza che s’inscena,
il grande lusso e come s’è ottenuto,
se equamente si versi del sudore
o il lamento sia espunto da un censore,
non sia nembo che annuvoli la rotta:
si taccia per un fine, che si soffra.
VII
Abbiamo sovrumano un vero Dio
da noi creato, rivale di astrazioni:
è Grande Nave, unico suo fine
apparente è l’unire due banchine,
invero il suo disegno è defecare
più risorse di quante ne divori.
Carlo Tosetti (Milano, 1969) vive a Sirtori (LC). Ha pubblicato le raccolte: Le stelle intorno ad Halley (LibroItaliano, 2000), Mus Norvegicus (Aletti, 2004), Wunderkammer (Pietre Vive, 2016), La crepa madre (Pietre Vive, 2020. Primo classificato al Premio Città di Chiaramonte Gulfi 2021; primo classificato al Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana 2021; secondo classificato al Premio Nazionale di Poesia L’Arte in Versi 2020). La teoria del Transatlantico (Edizioni Cofine, 2022). Suoi scritti e recensioni sono presenti su varie riviste e lit-blog, come: Nazione Indiana, Poetarum Silva, Larosainpiu, Versante Ripido, elvioceci.net, Lankenauta, Interno Poesia, giovannicecchinato.it, Poesiaultracontemporanea, Atelier poesia, Unpostodivacanza, Centro Cultural Tina Modotti, Menti Sommerse, Tragicoalverman, YAWP (giornale di letterature e filosofie), l’EstroVerso, Pangea, Laboratori Poesia, Poetry Sound Library, Inverso – Giornale di poesia, Perigeion, La tigre di carta, Il Giornalaccio, Poesia del nostro tempo, Cartesensibili, Limina Mundi, Menabò.
* Immagine di copertina creata da Mara Venuto con AI.